Elisabetta Vignato
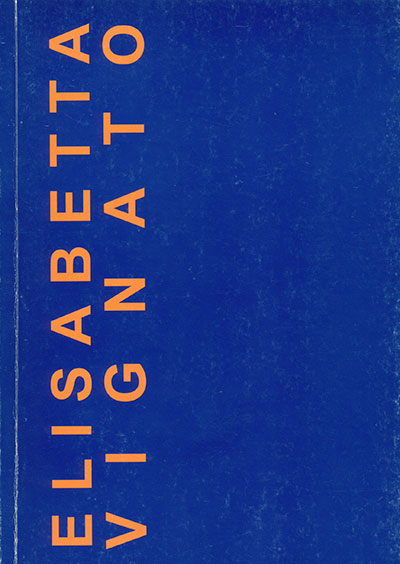
Memorie a raggi infrarossi
a cura di Alessandro Riva
C’è, nel vasto quanto prolifico panorama della giovane pittura italiana, un filone che ha saputo reinterpretare i tradizionali codici linguistici provenienti, più o meno direttamente, dalla storia dell’ accademia pittorica, in modo assolutamente nuovo e originale, tanto da riuscire a imporsi, attraverso un rimescolamento di carte tanto innovativo quanto, paradossalmente, strettamente legato alla propria storia e alla tradizione del proprio specifico ambito linguistico, come le prove più interessanti e significative della nuova scena artistica italiana. Sto pensando a quanti, in modi e con approcci tra loro differenti e a volte anche in aperta contraddizione l’uno con l’altro, hanno saputo dare slancio e vitalità a generi quali la pittura di paesaggio – come si usava dire un tempo – e alle forme tra loro sempre diverse del ritratto e, più in generale, della riflessione sull’identità e sulla figura umana (forme, è il caso di dirlo, che spesso partono dal proprio ambito più vicino e ristretto – sia quello famigliare che quello appartenente alla cerchia di amici e conoscenti-, nella rinnovata coscienza della necessità di ripartire dal piccolo, dal locale, dal micro, in breve dalla propria esperienza diretta e dal proprio nucleo affettivo, per arrivare al grande, al macro, alla mitica realtà globale di cui tanto si favoleggia in questi ultimi anni).
Che siano proprio questi due i filoni che maggiormente hanno saputo dare nuovi slanci e originali contributi alla storia recente della pittura italiana, ma anche di quella europea (e sto pensando, sopratutto per quanto riguarda la nuova ricerca sulla figura umana, ad artisti attivi in Inghilterra, come Alessandro Raho e Nicky Hoberman, ma anche a molti altri provenienti dall’ ambito tedesco e più in generale mitteleuropeo, come Bas Meerman, Muntean & Rosemblum o Till Freiwald); che siano questi i filoni maggiormente prolifici e portatori di novità è, dicevo, non un caso o uno scherzo del fato, quanto piuttosto una ineluttabilità storica, perchè è proprio sui grandi temi del luogo e dell’identità che si gioca oggi la partita del nuovo pensiero filosofico e teorico, Non c’è da stupirsi, allora, se alcuni artisti – e segnatamente alcune artiste – che in questi ultimi anni hanno vissuto una loro personale storia lontano dai riflettori della grande stampa o spesso anche tra la completa indifferenza della critica laureata (quella de l’avangarde pour l’ avangarde, che crede ancora che i grandi temi della riflessione sull’ identità frantumata si debbano per forza giocare sul terreno dei giochini sadomaso, del sangue & carne & merda buttati a palate sul pubblico, e non piuttosto su quello della riflessione colta che – al di là del linguaggio impiegato – tenga conto anche e sopratutto della propria storia e della propria specifica tradizione), non c’è da stupirsi, dicevo, se capita oggi di scoprire come alcuni artisti – e alcune artiste – si stiano muovendo, in maniera del tutto autonoma e con rara coscienza di ciò che il loro lavoro rappresenti, proprio lungo questi filoni di reinterpretazione e ridefinizione dei temi del paesaggio e del corpo: e penso, in questo caso, a pittrici come Barbara Nahamad, che del corpo mette in scena i lati più estremi e radicali; a Valentina D’ Amaro, che del paesaggio reale ha creato una strana replica sintetica, artificiale, che dal suo referente si differenzia soltanto per minuscoli scarti nei rapporti tonali o prospettici; e come, appunto, Elisabetta Vignato, che sugli stessi temi – il paesaggio ( prima esterno e poi interno) e il corpo – ha imbastito, e non da oggi, una sua ricerca che, pur guardando con interesse a tutto ciò accade in Italia e fuori, pare avere oggi assunto una sua originale personalità autonoma e radicalmente innovativa, sia nei modi che nell’ approccio linguistico e teorico.
Del lavoro di Elisabetta Vignato sono attratto e interessato da anni, pur non avendolo mai seguito realmente da vicino e “dal di dentro”, com’è invece accaduto con altri pittori più vicini a me per dislocazione geografica o per amicizia.
Tuttavia, avendolo conosciuto qualche anno fa grazie a non so quale caso fortuito, il suo m’è parso subito come un lavoro che si sapesse imporre per una forte carica di originalità e insieme di perfetta integrazione con ciò che stava accadendo in quegli anni (in questi anni) in Italia.
E lo sviluppo avvenuto nel tempo all’interno del suo lavoro, coerente come non sempre è facile che accada e tuttavia con una sua fortissima carica di tensione emotiva e poetica che sempre ne rinnovava la freschezza e l’interesse, mi ha via via convinto di aver di fronte uno dei, seppure non rari, perlomeno non poi così frequenti, lavori che valesse davvero la pena di seguire e approfondire. E infatti. Il lavoro di Elisabetta è cresciuto, in questi anni e sopratutto in questi ultimi mesi, in modo esponenziale, e con scarti e improvvise impennate che ne hanno approfondito il potenziale creativo e la carica di novità, facendolo connotare con un lavoro al tempo stesso assolutamente puntuale rispetto alla scena emergente europea di questi anni – perchè perfettamente in linea con quanto di nuovo sta avvenendo in Europa nel campo della ricerca pittorica- e allo stesso tempo con una carica poetica, una semplicità del segno e una felicità nell’utilizzo dei colori e dei toni che ne fanno un caso del tutto nuovo e originale all’interno del pur eterogeneo panorama della pittura italiana.
Dapprima concentrato sul corpo umano- e su quello femminile in particolare-, poi sul paesaggio urbano, quindi nuovamente sul corpo, ma questa volta con una particolare attenzione all’immaginario infantile, e su una sorta di astratto e insieme lirico campionario d’architetture d’interni che sempre hanno a che fare con l’esperienza infantile- in una anonima e allo stesso tempo calda e- vorrei dire- “fremente” teoria di aule scolastiche, sale-coloquio e corridoi appena delineati e abbozzati-, il lavoro della Vignato si è sempre mosso, e continua tuttora a muoversi, in una zona oscura del nostro immaginario: una zona fatta di vaghi ricordi malamente sopiti in qualche anfratto della nostra memoria, ricordi che paiono risvegliarsi soltanto se stimolati a dovere con odori e parole e segni e frasi appena sussurrate e tocchi di colore ben calibrati- una sorta di zona arcaica, remota del nostro cervello, dove si mescolano antichi ricordi d’infanzia che credevamo sepolti per sempre, odori di refezione scolastica, muri sbrecciati e banchi in legno e sedie in ferro su cui abbiamo passato, noi o i nostri figli -chissà- interminabili ore di noia e insieme di calda, avvolgente pigrizia. E questa zona arcaica, che ha a che fare con il lato più profondo e oscuro della nostra mente e della nostra memoria, viene stimolata da Elisabetta con una tecnica che, per una volta, si serve del medium fotografico unicamente come vaga base di partenza, o meglio come inevitabile referente a cui la pittura oggi non può più fare a meno di alludere e di rappottarsi, senza mai, però, che la forza simbolica di quello -del mezzo fotografico- diventi preponderante rispetto a quello della stessa pittura. Non c’è, insomma, come accade per esempio nel lavoro di Galliano o di Guida, l’esplicito riferimento alla fotografia come mezzo di estrapolazione di un istante qualsiasi del nostro presente, o di recupero di frammenti di memoria che altrimenti rischierebbero di andare perduti; c’è, semmai, un vago riferimento a qualcosa che tutti noi abbiamo, più volte, conosciuto e visto nel corso della nostra vita, e che la pittura riesce a stimolare unicamente con la forza della sua sottile e insieme fortissima capacità evocatrice. Basterà allora un tocco di colore e di toni tra loro omogenei per far diventare la sagoma di una sedia, di un banco o di una panchina un leggero filo che lega tra loro frammenti di ricordi “reali” e di ricordi soltanto immaginati o sognati -quelli indotti dalle migliaia di libri e di sussidiari e di film che abbiamo visto e letto sull’infanzia, quell’infanzia che noi stessi abbiamo vissuto e che abbiamo visto e sentito vivere da altri. E basterà, allora, un segno deciso ma soltanto abbozzato nell’ovale di un viso infantile per delineare, come accade con i versi d’un poeta, il viso di un bambino qualsiasi che può essere uno dei tanti che vediamo ogni giorno passare per strada o semplicemente il ricordo di ciò che noi stessi siamo stati, per un tempo, infiniti secoli fa. La pittura di Elisabetta Vignato è, per questo, insieme potentemente evocatrice della nostra più arcana memoria infantile e straordinariamente “reale”, concreta, rappresentativa di ciò che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno -bambini e bambine di oggi, che oggi, proprio oggi stanno giocando con finte pistole sotto gli occhi di mamme che si sentono ancora ragazze e che, da ragazze, continuano a vivere, a vestirsi, a scambiarsi sorrisi e parole e sentimenti e pensieri; è evocatrice di storie qualsiasi di oggi -storie intime, quotidiane, di affetti nati ieri eppure già ben radicati nel più profondo del nostro animo, e che pure, in una certa atmosfera che ha un non so chè di certi inizi primavera, o nel caldo riflesso d’una luce radente da tardo autunno italiano, ci appaiono, in virtù della loro semplicità – un segno appena per delineare i contorni d’un banco di scuola, una serie di verticali che ci compaiono davanti sul muro a ricordarci di com’erano fatti quei termosifoni che abbiamo visto mille e mille volte nei lunghi corridoi delle nostre antiche aule scolastiche (che sono in fondo il simbolo stranamente felice e malinconico dei tanti altri non luoghi che abbiamo visto e bazzicato tante e tante altre volte, in tante e tante altre vite, per millenni a venire, tra aule universitarie, uffici, stazioni, ipermercati e quant’altro); e poi quei corpi di donna che nascono come niente dal fondo incerto d’un ricordo, in virtù d’ un particolare qualsiasi -la silhouette di un paio di jeans, la spallina di una camicetta che sparisce nel buio d’una luce bluastra del fondo; ci appaiono, questi muti segni di un presente che è anche la memoria stessa del nostro passato che non vuole passare, come opachi ricordi sbalzati fuori da un chip improvvisamente risvegliato della nostra memoria – e guardate allora quei segni tracciati solamente dal loro riflesso di colore e di luce, guardate quelle figure indelebilmente stampate sulla tela dal fantasma del loro stesso ricordo, e ditemi se non vi ricordano le tracce insieme evanescenti e indelebili lasciate dal riflesso d’una bomba -atomica o idrogena o a raggi infrarossi, o di chissà che altra diavoleria tecnologica. Così, nella luce insieme delicata e accecante di un evento che è insieme una sorta di trauma -il cono di luce lasciato da una bomba, o il flash di un ricordo insieme doloroso e felice -e un delicatissimo evento poetico, si muove leggera e fluttuante la pittura di Elisabetta Vignato.